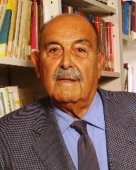Introduzione
Il concetto di psicopatologia grave si riferisce a disturbi psichici di elevata compromissione, in particolare le psicosi, caratterizzate da un’alterazione significativa della realtà, spesso con deliri, allucinazioni e compromissione del funzionamento globale dell’individuo. La definizione di psicosi si è evoluta nel tempo, passando da un concetto generico di “follia” (Feuchtersleben, 1845) a definizioni più specifiche basate sui criteri diagnostici dei principali manuali internazionali come il DSM e l’ICD.
Definizione e sintomatologia della psicosi
Secondo il DSM-IV-TR, il termine psicotico ha ricevuto numerose definizioni, nessuna delle quali universalmente accettata. Le definizioni più restrittive si riferiscono alla presenza di allucinazioni e deliri privi di consapevolezza critica, mentre definizioni più ampie includono sintomi come la disorganizzazione del pensiero e il comportamento catatonico.
I sintomi psicotici si distinguono in:
1. Disturbi della forma del pensiero, che includono incoerenza, fuga delle idee e alterazioni associative.
2. Disturbi del contenuto del pensiero, con ideazione delirante e interpretazioni erronee della realtà.
3. Disturbi della senso-percezione, con allucinazioni prevalentemente uditive e visive.
Questi sintomi possono presentarsi con eziologie e gradi di gravità differenti, influenzando la prognosi e le possibilità terapeutiche.
Schizofrenia: caratteristiche e sintomatologia
La schizofrenia è una delle manifestazioni più studiate della psicosi. Secondo Gabbard (1995), essa è una condizione eterogenea con sintomi suddivisibili in:
• Sintomi positivi: deliri, allucinazioni, disorganizzazione del pensiero.
• Sintomi negativi: appiattimento affettivo, ritiro sociale, apatia.
• Compromissione delle relazioni interpersonali, con difficoltà nell’interazione sociale e incapacità di mantenere legami significativi.
Una distinzione importante è stata introdotta da Carpenter (1988) con il concetto di “sindrome da deficit”, in cui alcuni sintomi negativi sono secondari a fattori come ansia e depressione, piuttosto che espressione diretta del disturbo schizofrenico.
Modelli eziologici della psicopatologia grave
L’ipotesi eziologica più accreditata è quella biopsicosociale, secondo cui fattori genetici, biologici e ambientali interagiscono nello sviluppo delle psicosi. Questo approccio ha permesso di superare vecchie teorie colpevolizzanti, come quella della “madre schizofrenogena”, e di focalizzarsi su una complessa rete di fattori di rischio e vulnerabilità (Stern, 2006).
Secondo Erikson (1950), un aspetto fondamentale nello sviluppo della personalità è la costruzione della fiducia di base, che permette la regolazione degli stati interni. Se questa fiducia viene meno, il bambino sviluppa un senso di impotenza, con ripercussioni sulla capacità di autoregolazione emotiva e cognitiva.
Zapparoli (2009) sottolinea come il deficit di fiducia e autoregolazione possa portare a una compromissione dell’identità, con esperienze di sé frammentate e una percezione del bisogno come minacciosa. Ciò si traduce in una difficoltà nel tollerare la frustrazione, nel regolare l’ansia e nel mantenere relazioni significative.
Trattamento della psicopatologia grave
Il trattamento delle psicosi si basa su un approccio integrato che combina farmacoterapia, psicoterapia e interventi riabilitativi.
1. Intervento farmacologico: Gli antipsicotici sono il trattamento di elezione per la gestione dei sintomi positivi, mentre la terapia farmacologica combinata può essere utile per la gestione dei sintomi negativi e dei disturbi dell’umore associati.
2. Intervento psicoterapeutico: Gli approcci psicodinamici, cognitivi e di sostegno mirano a migliorare la consapevolezza di sé, la gestione dei sintomi e le capacità relazionali.
3. Intervento riabilitativo: I programmi di riabilitazione psicosociale sono fondamentali per favorire l’inclusione sociale e il recupero funzionale.
Zapparoli (2002, 2009) enfatizza l’importanza di un intervento di supporto mirato a sostenere le funzioni deficitarie, attraverso una sorta di “protesi psicologica” che aiuti il paziente a sviluppare strategie adattative.
Nel contesto delle comunità terapeutiche, il ruolo degli operatori è cruciale per favorire un’esperienza correttiva e contenitiva che permetta al paziente di rielaborare le proprie difficoltà in un ambiente protetto. Questo approccio, che integra dimensioni psicodinamiche e riabilitative, può favorire la costruzione di un’alleanza terapeutica basata sull’accettazione dei bisogni del paziente.
Conclusioni
La comprensione e il trattamento della psicopatologia grave richiedono un approccio multidimensionale, che tenga conto della complessa interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali. L’intervento terapeutico deve mirare non solo alla riduzione della sintomatologia, ma anche al sostegno delle capacità residue del paziente, facilitando un processo di compensazione e adattamento.
Bibliografia
• Carpenter, W. T. (1988). The deficit syndrome in schizophrenia: Implications for research and therapy. Schizophrenia Bulletin, 14(4), 567-576.
• DSM-IV-TR. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association.
• Erikson, E. (1950). Childhood and Society. W.W. Norton & Company.
• Feuchtersleben, E. von (1845). Principles of Medical Psychology.
• Gabbard, G. O. (1995). Psichiatria psicodinamica. Raffaello Cortina Editore.
• Pine, F. (2009). In G.C. Zapparoli (Ed.), Psicopatologia e trattamento delle psicosi.
• Stern, D. (2006). Il mondo interpersonale del bambino. Bollati Boringhieri.
• Zapparoli, G. C. (2002). Il trattamento delle psicosi nell’area del deficit. Franco Angeli.
• Zapparoli, G. C. (2009). Psicopatologia e trattamento delle psicosi. Franco Angeli.